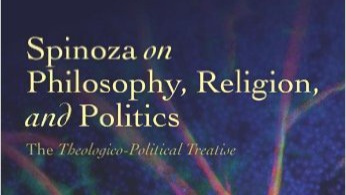È difficile, per un amante della conoscenza, resistere al fascino dell’Antica Grecia, alle suggestioni legate a quella civiltà che, dando alla luce la filosofia, ha aperto le porte alla razionalità e all’utilizzo sistematico del pensiero. Ma quali sono state le condizioni che hanno favorito l’emersione di un fenomeno tanto straordinario e decisivo per la storia dell’Occidente? Cosa c’era nella civiltà greca prima del pensiero filosofico e qual è il suo rapporto con quest’ultimo? Uno dei tentativi di risposta in assoluto più interessanti a simili quesiti, è quello contenuto in Psiche. Culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci del filologo tedesco Erwin Rohde, che tra il 1890 e il 1894, calcando l’intuizione dell’amico di giovinezza Friedrich Nietzsche, gettò una nuova luce sulla cultura greca degli albori. Con La nascita della tragedia (1872) infatti, Nietzsche aveva letteralmente sconvolto il mondo filologico europeo del tempo (impietoso fu l’attacco che gli rivolse Wilamowitz), incalzando l’immagine tradizionale di una società votata alla serena e solare compostezza propria della religione olimpica, svelò l’esistenza di una sua dimensione“notturna”, profondamente passionale e irrazionale: lo spirito dionisiaco. Scuotendo la civiltà greca fin nelle sue fondamenta, questa esperienza riuscì ad aprire una breccia nel muro che lo spirito apollineo (il baluardo difensivo del kosmos olimpico dall’infuriare del kaos originario e dalla sua istintualità) aveva eretto fra l’uomo e la divinità, così da riportare nella sfera umana quell’immortalità che aveva perso con la fine delle fedi arcaiche e che renderà indispensabile la nascita della filosofia per trovare un nuovo fondamento capace di resistere ad ogni secolarizzazione.
Il TTP: un libro forgiato all’inferno o in paradiso? (Parte prima)
Il Trattato teologico politico (TTP) di Spinoza, pubblicato nel 1670, costituisce uno di quei rari testi filosofici che, a distanza di oltre tre secoli, continua ancora oggi a produrre una mole notevole di studi e letteratura critica. Il libro di Susan James, Spinoza on Philosophy, Religion and Politics, pubblicato nel 2012, costituisce un profondo e dettagliato studio che si aggiunge agli altri apparsi recentemente ((Vedi a questo proposito Steven Nadler, A book forged in Hell (tr. it. Un libro forgiato all’inferno, Einaudi, 2013)). Il suo scopo, come indicato esplicitamente nell’introduzione, è quello di ricostruire il contesto storico che ha dato forma al trattato confrontando i vari temi in esso contenuti con il dibattito e le lotte in corso in quel periodo. Come spiega l’autrice, questo approccio è particolarmente utile se si tiene conto del fatto che Spinoza ha redatto i suoi scritti per diversi destinatari e per differenti scopi in modo tale che sarebbe controproducente, e dannoso per la sua stessa comprensione, assumere il suo sistema come un tutto coerente forzando la sua interpretazione all’interno di un’unica lettura. Non manca tuttavia la discussione analitica di alcuni problemi teologico-filosofici: filo comune dell’analisi è il confronto con il calvinismo, la religione dominante nell’Olanda del seicento, anche a motivo del fatto che molte delle tesi di Spinoza riprendono, per distinguersene, i dogmi della principale e più rigida delle sette protestanti.

Se si considerano le tre ragioni che spinsero Spinoza a scrivere il TTP, indicate dallo stesso autore nella lettera a Oldenburg del 1665 ((Epistola XXX)), l’interpretazione della James prende in esame la seconda: evidenziare cioè come l’accusa di ateismo sia sempre stata respinta dal pensatore olandese il quale proprio sull’idea di Dio costruisce la sua filosofia. In questo senso il testo della James presenta uno Spinoza religioso, impegnato piuttosto a combattere la superstizione e l’ignoranza per mettere in luce il vero significato della religione. L’interpretazione della James si pone come alternativa e complemento a quella di altri studiosi ((Come ad esempio Jonathan Israel, Radical Enlightenment, Oxford University Press, 2002)) che tendono a leggere nelle pagine del TTP uno Spinoza laico, libertario, teso a distruggere i pregiudizi della religione al fine della libertà di filosofare.
Il libro è suddiviso in 12 capitoli organizzati in quattro parti: la Rivelazione, cioè i modi nei quali Dio si manifesta all’uomo; la demistificazione della Scrittura, ovvero perché la Bibbia non può essere intesa in senso letterale come Parola di Dio; l’adesione alle esigenze della vita religiosa, cioè i criteri della religione autentica; la politica della vera religione, dove viene preso in esame in che modo quest’ultima può trovare spazio nella società. Continue Reading
Il neoateismo come nuova forma di fede
 Appare evidente che emergano sempre di più, nel dibattito delle idee e delle opinioni, alcune concezioni radicali del mondo, le quali espellono in modo dogmatico qualsiasi alternativa, dando per scontato che il loro “punto di vista” sia il vero punto di vista. Ciò, nella storia del pensiero, si è sempre manifestato. Tuttavia, oggigiorno, alcuni dei più forti integralismi provengono da aree geografiche del pensiero che, nella storia, hanno sempre subìto la pressione di integralismi più forti e vincenti.
Appare evidente che emergano sempre di più, nel dibattito delle idee e delle opinioni, alcune concezioni radicali del mondo, le quali espellono in modo dogmatico qualsiasi alternativa, dando per scontato che il loro “punto di vista” sia il vero punto di vista. Ciò, nella storia del pensiero, si è sempre manifestato. Tuttavia, oggigiorno, alcuni dei più forti integralismi provengono da aree geografiche del pensiero che, nella storia, hanno sempre subìto la pressione di integralismi più forti e vincenti.
Vorremmo cominciare a ragionare, quindi, su un nuovo integralismo che, da qualche anno sta da una parte conducendo giuste battaglie per il riconoscimento e la libertà, ma dall’altra si concentra nella pratica dogmatica di affermare se stesso come unico e indiscutibile orizzonte di verità.
Si sta parlando del così detto neoateismo, dei quali fanno parte – per dire alcuni nomi – il compianto Cristopher Hitchens, Richard Dawnkins, Daniel Dennet, Sam Harris. La migliore definizione di questo “movimento”, il quale, nonostante alcune differenze, converge in modo quasi totale verso la definizione che ne dà nel suo ultimo volume Eugenio Lecaldano: «il neoateismo indica nel non credere e in un’esplicita negazione dell’orizzonte religioso una fuoriuscita dalla gabbia delle contrapposizioni che così fortemente segnano il nostro tempo. L’ateismo […] viene così proposto come l’unica prospettiva in grado di evitare le guerre di religione che sembrano avere segnato i primi anni del XXI secolo» ((E. Lecaldano, Senza Dio, Bologna, Il Mulino, 2015, pp. 42-43.)).
Un dialogo su Dio
Paride Petrocchi (moderatore): Cominciando dal professor Alici, incominciamo la serata partendo da questa prima questione. Ad una prima lettura del passo di Dostoevskij dove si dice che Se Dio non c’è tutto è lecito, ne “I fratelli Karamazov”, la frase sembra chiara. Poi in realtà emerge una complessità che inizialmente non era stata avvertita. Perciò: come possiamo interpretare questa frase di Dostoevskij? E d’altra parte, in forma di domanda: Se Dio non c’è, è veramente tutto lecito?
Prof. Luigi Alici: Debbo premettere una parola di gratitudine per avermi invitato qui, stasera. Sono davvero contento di essere davanti a così molte persone, amici e studenti che attestano interesse per delle questioni, sicuramente, molto impegnative e più grandi di noi. Sono contento di dialogare con un collega che stimo tantissimo, premettendo dal mio punto di vista come situare questo tipo di rapporto, utilizzando una espressione che il Cardinale Martini, negli ultimi anni ha ripetuto molto spesso. E cioè: noi dialoghiamo veramente con tutti se impariamo già a dialogare dentro di noi, con quella parte non credente che – in un certo senso – tallona la parte credente di ognuno di noi. Questo è un dialogo che non sostituisce l’altro, ma che resta fondamentale.
Qualcuno di voi, forse, avrà letto un libro – non certo accademico – intitolato Cielo di plastica, nel quale ho cercato di sviluppare questa tesi (che richiamo per delineare lo spirito del mio intervento): nell’intero corpus della Bibbia mi pare di capire, e non sono il solo, la vera differenza che attraversa la scrittura non è quella che intercorre fra credente e non credente. La vera differenza che dovrebbe far scattare un dialogo impegnativo è tra la fede e l’idolatria. La figura che, in tutta la Scrittura, volta le spalle a Dio non è l’ateo, ma è l’idolatra. Si tratta, in realtà, di interrogare le convinzioni profonde delle persone; perché in fin dei conti chi non ha convinzioni profonde?
Il testo di Dostoevskij è impegnativo, e contiene una domanda grande. E noi che siamo abituati a dare risposte piccole, abbiamo paura delle domande grandi. Tornare ad aprire il file delle domande grandi forse è un aspetto che giustifica lo stare insieme, qui stasera.
Nel 1946 il filosofo francese Jean-Paul Sartre tiene una conferenza che ha subito un certo successo e che si traduce in un libro intitolato L’esistenzialismo è un umanismo. Un libro nel quale Sartre – dopo una serie di scandali e polemiche esplose dopo la pubblicazione de L’essere e il nulla, per il quale era stato accusato di essere un pessimista dai credenti, dai cristiani, e un quietista dai marxisti – riprende Dostoevskij e in un certo senso lo esplicita, per noi, oggi. Lo esplicita in un contesto culturale che noi sentiamo più vicino; dirà esplicitamente che la frase dello scrittore russo, se Dio non esiste tutto è permesso, è il punto di partenza dell’esistenzialismo, che è quell’approccio secondo il quale l’esistenza precede l’essenza. Cioè esistere è stare allo scoperto, senza una copertura dottrinale o dogmatica. La copertura viene dopo, e bisogna sceglierla. In questo orizzonte delle scelte possibili Dio è un intralcio, rappresenta qualcuno che “mette dei paletti”, che delimita normativamente. E Sartre aggiunge che siamo soli, senza scuse: “l’uomo è condannato ad essere libero”. Ecco, vedete: Dostoevskij aiuta Sartre a tirare fuori questa frase che sarà, poi, uno slogan dell’esistenzialismo.
Vorrei ora provare a decodificare due ipotesi di lettura, sulle quali vorrei tornare, poi, nel secondo intervento.
Certamente nel modo in cui la domanda è posta c’è una infrastruttura concettuale dalla quale dovremmo prendere le distanze. Sia in Sartre che in Dostoevskij vi è un certo modo di intendere Dio, cioè come l’autore della legge, come auctor che dilata il suo potere fino a tradurlo in una imposizione normativa. Un Dio così è certamente un intralcio, perché autore di una legge estrinseca.
L’altra questione è il modo in cui viene codificato il lecito e il permesso. Perché tutto il problema morale, se lo ristringiamo a questa frase, cercando di venirne fuori senza problematizzarla, alla fine si prende questa strada: tutta la legge (autore della quale è Dio) è giocata dentro i confini del permesso. Se Dio c’è da lui abbiamo qualche permesso, se lui non c’è il cavallo del lecito può scorrazzare, perché è stato tolto tutto il recinto.
Il lessico del lecito, in etica, è ricorrente: ma mi permetto di dire che non è la prima parola. Forse è la seconda.
Se si imposta il discorso così, però, non se ne esce. Perché Dio è un padre padrone e dettando le regole detta i confini, dettando i confini nel momento in cui ci dà la libertà se la riprende; e una libertà così circuita, è mostruosamente snaturata.
Passando alla seconda ipotesi di lettura, ci si chiede: il vero problema morale si circoscrive nei termini dell’illecito, oppure forse dobbiamo superare questa visione e giocarla in un altro modo. La morale ci dovrebbe aiutare a star su di morale perché al cuore dell’etica c’è questo messaggio: tu puoi essere di più, tu puoi dare di più, tu puoi fare di più, tu puoi dilatare gli orizzonti della tua vita; questo significa star su di morale. Chi non riesce a cogliere questo messaggio rischia di essere de-moralizzato. Da questo punto di vista forse si smonta il dilemma di Dostoevskij, che pur restando valido nella sua portata provocatoria, ripropone la questione in un senso diverso: se è vero che l’essere umano è identificato da una dilatazione di orizzonti che in termini diversi abbiamo capito potersi chiamare libertà, allora il vero problema dell’etica è dilatare tali orizzonti e non restringerli. Il problema morale s’inscrive all’interno di questo contesto, non viene dall’esterno per opera di un’entità sovrannaturale che emette una sentenza. Tuttavia una domanda resta, in questo poter essere di più qual è la misura? In etica c’è certamente una componente normativa, ma non è che una mediazione, cioè la norma è il medium che ti permette di raggiungere nel modo più efficace, condiviso e positivo il bene; ma la norma è funzionale al bene. Se l’etica perde di vista la spinta verso il bene, se la nostra non è una vita innamorata del bene, ma è una vita ossessionata dal lecito come una spada di Damocle, dimentichiamo che il male non è che una variabile secondaria che insidia il primato del bene.
Tutto questo per difendere una visione positiva dell’etica, in cui io scopro il limite, il confronto con gli altri, la paura di fare male e di farci male, solo se mi chiedo: in questo essere di più c’è una misura o no? In questa chiave non c’è spazio per la visione idolatrica del Dio padre padrone, e il credente vero non può che essere l’alleato di chiunque voglia liberarsi di una visione idolatrica di Dio. Se il credente ha paura di chi rifiuta una visione idolatrica di Dio, la sua è una fede molto debole.
Prof. Filippo Mignini: Mille grazie per questo invito, ma prima di cominciare io vorrei dire una cosetta agli iscritti alla Fuci che non ne fossero al corrente, e cioè che la Fuci è stata fondata nel 1895 da Romolo Murri a casa sua. All’inizio degli anni Quaranta c’è stato un tentativo di mistificazione a riguardo; ho trovato nell’archivio Murri di Gualdo una lettera di Giulio Andreotti, che era segretario nazionale della Fuci al tempo, che aveva pubblicato un articolo su un giornale nel quale sosteneva che la Fuci era stata fondata da un’altra persona. Quando Romolo Murri legge questo articolo va su tutte le furie, scrive al direttore del giornale per informarlo sulla realtà dei fatti, e c’è una lettera un po’ ambigua di Andreotti in risposta. Questo per sottolineare il retroterra di questa associazione, oramai secolare.
Vengo alla questione, spesso quando si legge questa frase, la si trova nella forma esclamativa: “se Dio non c’è, tutto è permesso!”, ma non è così nel testo dei fratelli Karamazov non è così che viene posta la questione. Dal contesto noi non possiamo trarre la conclusione che, come si legge spesso nella vulgata, se Dio non c’è tutto è permesso. Questo è un passaggio altamente drammatico in cui un detenuto in attesa del giudizio definitivo e probabilmente della sua condanna, s’interroga sulle questioni fondamentali dell’esistenza, e quindi l’etica, della quale non sa cosa sia, quale siano i suoi rapporti con la scienza, però sa che al fondo c’è il problema di una certa idea di Dio che lo tormenta. Si chiede insomma se l’etica possa andare per conto suo, procedere anche senza Dio, oppure se non si dia un’etica indipendentemente da una certa idea di Dio, e in particolare dall’idea di Dio della tradizione cristiana. Quindi il Dio di cui si parla ha una precisa connotazione storico-critica. Come diceva Alici poco fa, noi dobbiamo liberarci di un’idea di Dio padre padrone, di un Dio legislatore e giudice, ma sta di fatto che nella storia dell’Occidente cristiano Dio è stato presentato prevalentemente proprio come un legislatore e un giudice. E proprio questa è una delle sue connotazioni principali ossia quella del giudizio che attende la parte eterna o sempiterna di ciascuno di noi e che è quella che conta. Dunque questo Occidente si porta dietro questa idea di Dio che pesa ed è normale che il povero individuo in attesa della condanna s’interroghi su una tale questione, chiedendosi se la sua esistenza possa essere giudicata in un modo o in un altro. Per la verità lui qui non accenna alla sua preoccupazione per la sua vita futura, sembra che non la consideri e che sia preoccupato più da una questione filosofia che da una questione esistenziale riguardante il proprio destino. Per questo si chiede se possa esistere un’idea di virtù universale che valga per lui come per il cinese.
Sta di fatto che tutto è posto in termini altamente problematici, non c’è una tesi che viene sostenuta, è come se venisse messa al vaglio un’intera tradizione storica e filosofica e teologica che costituisce un tormento per chi parla. Tant’è che egli non dice “mi dispiace per Dio”, cioè dinnanzi alla scienza che cresce mi dispiace per Dio come se avesse una sorta di malinconia, ma dice “mi dispiace di Dio”, è come se fosse dispiaciuto di questa idea di Dio. Questo è il punto veramente centrale in questione.
Moderatore: La seconda è una domanda un po’ complessa e riguarda proprio il tema dell’esistenza o meno di Dio, e il rapporto tra la libertà e la responsabilità umana. Cioè, se Dio esiste in quale rapporto è, se c’è, con la libertà e la responsabilità umane? E se non c’è qual è il ruolo della libertà e della responsabilità umane?
Prof. Alici: Le questioni sollevate da questo dibattito sono senz’altro molto interessanti, io sono d’accordo con il discorso appena fatto da Mignini tranne che per l’affermazione che l’idea di Dio come giudice è costitutiva per la tradizione cristiana. Io quest’affermazione la problematizzerei, poi si tratta di capire, perché la giustizia in senso biblico indica la fedeltà di Dio a se stesso. Se noi approcciamo questa idea di giustizia in senso legalistico, viene fuori quell’idea del giudice che ha certamente prevalso nella tradizione cristiana, ma che certamente un credente non può arrendersi ad accettare come costitutiva. Basterebbe pensare a tutta la linea della mistica femminile che ha attraversato tutta la tradizione cristiana e ha scommesso sull’idea del lato misericordioso dell’amore, cioè di un Dio che è un padre materno e non solo un giudice. Questo è un elemento che un credente, oggi, è chiamato a far venir fuori.
E allora io colgo questo input dentro una riflessione che per un verso tiene conto di quello che chiedeva Paride, per un verso dovrebbe servire a completare il mio intervento precedente.
Affrontiamo il problema subito, in maniera diretta: certamente la differenza tra un cristiano ed un non cristiano non è etica. Questa è una affermazione che un credente non si dovrebbe, nemmeno lontanamente, sognare di coltivare. Perché non c’è una differenza morale. Non è che il credente è una persona più buona. Anzi: quasi mai è così. Io, come modesto cristiano, avrei paura di una chiesa di perfetti, non ci potrei entrare. La fede non è un’etica, è molto più che un’etica; ma non è primariamente un’etica.
L’etica sta – prima ancora che in una dottrina morale – dentro la vita, perciò sta dentro la vita di ogni persona che si interroga, che cerca di articolare una differenza fra il giusto e l’ingiusto, tra bene e il male, fra il fisiologico e il patologico, tra la luce e l’ombra. Dentro la vita di ognuno di noi sta il “morale”, non è che l’hanno inventato i filosofi in laboratorio.
La filosofia sta alla vita morale, come l’anatomia sta all’atletica. Ovvero: un individuo che ha fatto le olimpiadi può aver fatto una prestazione straordinaria, senza conoscere il nome dei muscoli che ha utilizzato. Perché la ricognizione dottrinale sulla vita è una cosa di secondo livello, non è che la medicina sportiva si inventa un’anatomia. L’anatomia c’è, dà dei nomi ai muscoli. Certamente le dottrine morali sono dei tentativi di concettualizzare questa idea primaria di vita morale, viene concettualizzata con declinazione diverse a seconda di molte variabili, però: così come la vita biologica ci interpella e precede la scienza biologica, allo stesso modo la vita morale ci interpella e precede le dottrine morali. L’etica va nel senso genuino dell’educazione (cosa, oggi, quanto mai tradita e in controtendenza), cioè dell’educere e non dell’imbuere. La riflessione morale ti deve aiutare ad elaborare questo itinerario, alla luce della differenza tra bene e male, e alla luce del fatto che davanti al riconoscimento della differenza tra bene e male non posso essere uno spettatore disinteressato. Questo è l’elemento costitutivo, perché io sono coinvolto in questa differenza e avverto la necessità della mia risposta. La responsabilità è la seconda mossa della libertà, perciò non posso assumere la posizione dello spettatore disinteressato dinanzi alla differenza fra bene e male che attraversa la mia vita.
In quale misura, allora, gioca la riflessione cristiana?
Noi sappiamo che nell’Antico Testamento a Mosè vengono date le tavole della Legge, ma esse sono la mediazione normativa che nasce all’interno di un’alleanza. La prima mossa è il riconoscimento dell’alleanza, e ciò avviene all’insegna dell’amore. Qui non c’è nessuna forma di giustizia, di legalismo, perché la giustizia opera, fortunatamente, correggendo la logica della violenza, che si esprime con la dialettica “il mio è il tuo”, sostituendo con la logica “il mio è mio, il tuo è tuo”. Ma nella fede cristiana sappiamo che tutto è cominciato con un atto dove il mio diventa tuo. I comandamenti sono una forma di codificazione ausiliaria, perché se tu ci stai in questa avventura io ti indico una strada, per non perderti. Poi insieme, voi, la rettificherete; vi è una relativa pluralità di concettualizzazioni. Allora io avverto, e qui non posso nascondermi, ma devo anche testimoniare, che in tutti i momenti nei quali ho una forte nostalgia di un Dio padre-padrone che mi risolve i problemi, che mi divide il mondo in buoni e cattivi e mi porta a pensare che se uno non crede in Dio così come ci credo io quella è una persona perduta, in quel momento deve suonare un terribile campanello d’allarme. Spesso cito un testo di Kierkegaard, che secondo me è molto istruttivo, in una predica di missoria, cioè in una esercitazione per l’esame al pastorato (che poi non ha mai fatto) usa questa immagine potentissima: se la fede è debole, per non farsi vedere, indossa una corazza, è come quando in un duello medievale troviamo un cavaliere con una corazza lucente e lì dentro c’è una persona rachitica e piena di paura. Quella persona al primo colpo va a terra. Quella corazza non è servita a niente ed è stata una bugia.
Anche per ciò il credente ha sempre un problema in più, con l’etica. Perché si tratta di interrogarsi sulla possibilità di un rapporto di tipo filiale che però è costantemente sottoposto ad una regressione autoritaria, nel senso che indicava prima Mignini. L’idea del giudice mi risolve moltissimi problemi, ma la storia dietro questa deriva legalistica ha fatto scorrere fiumi di sangue, perciò vale la pena ritrovare la cifra dell’alleanza dentro la quale ha senso anche la legge, dentro la quale ha senso riconoscere la mia fragilità, dentro la quale non ci perde nulla il mio messaggio cristiano, certamente ci guadagna se mi tolgo la corazza, e certamente rispetto alla giusta problematicità di Dostoevskij la schematica assertorietà di Sartre mi mette in grandissima difficoltà. Perché nemmeno io vorrei credere in quel Dio dal quale lui stesso scappava. Forse lui è scappato da un fantasma, che a volte ci fa anche comodo, perché ci conferma nella nostra piena autonomia.
Da questo punto di vista, quella spinta verso il bene che caratterizza la mia vita, come nelle mie cellule c’è una spinta verso la salute, va verificata con Dio, così come si verifica con un amico, dentro ad una comunità.
Oggi l’etica è come la salute, ne parlano tutti quelli che stanno male.
Nell’89 è caduto il Muro di Berlino, l’11 settembre è caduto un altro muro, e poi dal 2006-2007 è caduto il muro che divideva la finanza dall’etica. Davanti a queste cose, credenti e non credenti, non possono dividersi. Le domande fondamentale dell’etica vanno affrontate, dagli uomini di buona volontà, insieme. Solo dentro la cifra dell’alleanza, l’etica cresce. Poi certo, il credente deve anche rispondere a qualcos’altro.
Prof. Mignini: veniamo subito alla questione centrale e scottante. È necessario che io vi dica cosa pensi di Dio, perché sennò non ci capiamo.
Io considero Dio come l’Assoluto, la causa sui, l’esistenza necessaria. Insomma: quella necessità dell’esistenza grazie alla quale qualsiasi mia rappresentazione o concetto relativo al mondo, relativo all’ente, diventa possibile. Io non posso pensare nessun ente se non so, se non assumo, che l’ente esista per necessità di esistenza. Perché se all’origine ci fosse il nulla o il non-essere, nulla ci consentirebbe di passare all’essere. Ma siccome noi ci troviamo nell’essere allora l’essere, che noi decliniamo nelle varie forme nella nostra esperienza, pone e suppone che ci sia una necessità dell’essere. La necessità dell’essere è Dio.
Questo significa che se Dio, come necessità dell’essere, è absolutum deve perdere ogni tratto antropomorfico, perciò non deve assomigliare in nessun modo alla nostra esperienza quotidiana. Quindi: né padre, né madre, né fratello, né sorella, né amico, né amante, né odiante, non persona, non soggetto, Dio non è un “tu” al quale io mi possa rivolgere. Perché se fosse un “tu” sarebbe finito, la mia esistenza lo finirebbe, sarebbe un altro e non l’Assoluto. Ciò significa che io sono ateo? No, non credo. Non si tratta di essere atei, ho semplicemente un’altra idea di Dio. Io, questo sì, non credo che sia necessaria la fede come strumento per “relazionarci” a Dio, perché Dio non è oggetto di fede. Dio è l’idea più chiara e distinta che noi possediamo, perché se non avessimo questa idea chiara e distinta della necessità dell’esistenza, non potremmo pensare niente. Quindi io la fede la riservo ad un altro ambito, all’ambito della vita pratica. Ho bisogno di fede nei rapporti con mia moglie, con i miei studenti, con il negoziante dal quale vado a comprare il pane e la frutta… A loro devo attribuire un credito, rispetto a certe cose che io non riesco a controllare. Da questo deriva il fatto che con Dio non si parla e che Dio non parla. Che bisogno avrebbe di parlare, Dio? Dio non è una persona. Dio è talmente intimo a ciascuno di noi che non ha bisogno di parlarci, perché noi stessi parlando, parliamo in nome di Dio.
Voi dite, ma come, il figlio, nel romanzo di Dostoevskji, che ha appena ucciso il padre, questo parla in nome di Dio? In un certo senso sì. Infatti non riesce a parlare altro che di Dio, ma non di quel Dio che lo tormentava e di cui non era contento.
Se noi esistiamo in quanto siamo costituiti, intimamente, essenzialmente, della stessa natura dell’essere necessario, è chiaro che tutto ciò che facciamo e tutto ciò che esprimiamo lo facciamo in forza dell’unica potenza che esiste in natura, cioè la potenza divina. Non ci sono altre potenze. Non c’è Dio e qualcos’altro. Perché se ci fosse un qualcos’altro capace di costituirsi autonomamente rispetto a Dio, Dio non sarebbe più Dio, cioè non sarebbe più l’Assoluto.
Dunque: come si vive in questo silenzio di Dio? Dove, ripeto, il silenzio di Dio è il silenzio di una certa idea di Dio, di una certa rappresentazione di Dio, di un Dio che si mescola continuamente con le cose umane, di un Dio che dice di prendere un popolo e di eleggerlo a suo popolo servendosene per farsi riconoscere a tutti i popoli della terra. Agli altri popoli non si sarebbe manifestato.
Quando arriva, a tal proposito, la prima delegazione romana, alla corte dell’Imperatore di Cina nell’anno 1705, e pretendono che i cinesi non chiamino Dio la divinità “Cielo”, l’imperatore gli dice: ma scusate, a parte il fatto che noi consideriamo cielo una metafora, perché noi, nelle cui terre, il signore del cielo, non si è incarnato, non avremmo potuto utilizzare questo nome, per indicarlo? Il tema dell’elezione del popolo è un tema che ha diviso, che ha condotto – come diceva il professor Alici prima – ad una serie di tragedie e di guerre, delle quali l’Europa è stata una testimone molto sofferta.
Riprendiamo: come si vive in questo silenzio di Dio? Direi, insomma, che si può vivere bene. Perché? Perché all’uomo viene data la totale responsabilità della sua esistenza. All’uomo non manca nulla per sapere come comportarsi, come guidarsi, dove andare, che cosa è necessario fare per condurre una vita felice e per costruire delle società capaci di garantire i beni supremi della esistenza e dell’esperienza umana, cioè la sicurezza e la libertà. All’uomo che non manca nulla, lo sa. Gli antichi greci e romani – pensate voi alla tradizione stoica, da Cicerone a Seneca, a Marco Aurelio a Epitteto – non sentivano minimamente il problema di una mancanza di dialogo con una divinità che gli parlasse. Sapevano benissimo quali erano le virtù cardinali. Le virtù cardinali, infatti, le hanno inventate i greci e i romani, sono poi state prese in eredità dai cristiani, ma le trovate tutte espresse già negli stoici. Tant’è che in Seneca l’honestum si ha quando si hanno presenti tutte e quattro le virtù cardinali.
Allora: in che cosa consiste la virtù fondamentale? Quella virtù della quale si chiedeva anche nel dialogo dei due fratelli, in Dostoevskji. Il modello della virtù consiste in quell’idea di humanitas, di umanità, che hanno elaborato i filosofi romani. L’essenza della humanitas consiste in una cura che l’uomo deve avere per se stesso e per il prossimo, questa cura o esercizio di responsabilità, Seneca la chiama caritas. Non eros, ma caritas. E fa l’esempio di una volta di pietre che si tiene perché le pietre sono disposte in un certo modo, e tutte esercitano la loro pressione sulla pietra centrale. Allora: una società si regge se tutte le parti sono così coese e se ciascuna parte svolge il proprio ruolo, cioè la propria funzione, sapendo cos’è e chi è, ha cura di se stessa e ha cura delle cose che gli stanno intorno, cioè del mondo, della natura, della società, dell’umanità.
Matteo Ricci, del quale mi sono occupato lungamente negli ultimi anni, scopre – leggendo i testi cinesi – che l’essenza del confucianesimo sta in una virtù che corrisponde esattamente alla nozione di humanitas dei latini. Perché questa virtù fondamentale di cui parla Confucio, in cinese ren (si pronuncia gien), è tradotta con il significato di umanità, carità, benevolenza e cose di questo genere. Essa consiste nella conoscenza del proprio ruolo e della propria posizione in questo cosmo, nel cielo e nella terra, e nella cura che ognuno di noi ha nei confronti di se stesso e del prossimo. Su questa comunanza di idea di virtù che si instaura il grande ponte che Matteo Ricci riesce a costruire con i cinesi, e lì non ha utilizzato nessuna metafisica e nessuna ontologia, niente di tutto ciò. È su questo piano di comprensione naturale e razionale, di esseri dotati di ragione, che nasce la nozione di humanitas, e che prescinde da ogni idea di Dio. Ricci, infatti, presentava ai cinesi gli stoici “un poco cristianizzati”; voleva dire che non presentava dello stoicismo il tema del fatalismo o del suicidio. Per il resto, però, la prospettiva occidentale che meglio si adattava alla cultura confuciana era, appunto, lo stoicismo. E quando deve spiegare agli occidentali chi è Confucio dice è un altro Seneca. Dico questo per dire che certamente è possibile un’etica e una morale. Del resto, quando in Europa arrivano numerosissime lettere e relazioni dei religiosi, a cominciare dall’ultimo decennio del ‘500, per tutto il ‘600 e buona parte del ‘700, l’Europa deve confrontarsi con delle sfide dettate da dati di fatto, ossia: abbiamo sempre ritenuto che sia impossibile una società di atei, ma in Cina c’era un intero popolo che nell’ottica occidentale è considerato ateo, e che ha costruito il miglior modello di società che si conosca (così i gesuiti descrivevano la società cinese). Ricci in una lettera scrive: i cinesi hanno messo in pratica più di quanto Platone, nella Repubblica abbia soltanto saputo immaginare.
Domande dall’uditorio:
1. Qual è (in questo discorso mi sembra non sia emerso) il rapporto fra etica e razionalità? In che modo l’etica può scaturire dal pensiero? Il pensiero può fondare un’etica?
2. Io vorrei approfondire la questione del Dio giudice, perché stando alla Bibbia Dio non è tanto un giudice, quanto più una guida continuamente il suo popolo. Detto questo: quanto, nella modernità, nel definire il concetto di Dio, ha influito l’idea di un Dio giudice, piuttosto che un Dio guida che è più aderente al testo sacro.
E inoltre, soprattutto riferendomi al professor Mignini: avere un’idea di Dio non è già ridurre Dio? D’altra parte: pensare che Dio non possa nella sua infinita potenza manifestarsi, perché ha piacere di farlo (come invece inizia il testo del Concilio Vaticano II, piacque a Dio…), questo non è già una limitazione del potere divino? Non è un atto antropomorfo, rispetto alla critica che lei poneva in precedenza?
3. Molto spesso Dio viene collocato in un’idea di Bene, di un Bene ontologico, però: ancor prima di parlare di ciò che è lecito, come è possibile distinguere il bene e il male?
4. Soprattutto al professor Mignini: quando lei prima si chiedeva se si potesse vivere bene in questo silenzio di Dio, dicendo che l’uomo non manca di nulla al fine di fondare una società e di raggiungere la felicità, sottintendeva un’idea di Dio come Assoluto. Come è possibile costruire una società giusta, date queste premesse, togliendo dal discorso un’idea di Dio come rapporto?
Prof. Alici: Rispondo in maniera telegrafica, relativamente alla prima questione: certamente la capisco e riavvolgendo indietro il film delle cose che ho detto mi rendo conto che forse posso aver dato un’impressione vitalistica dell’etica. La razionalità è un oggetto molto ingombrante per i filosofi, perché si può semantizzare in tanti modi. Può essere uno strumento di supervisione, attraverso il quale gli uomini comunicano e valutano insieme, interpretandola, la propria vita. In questa accezione qui è essenziale questo controllo, per evitare che l’etica travesta e oscuri le peggiori pulsioni dell’uomo. Il controllo razionale sull’etica è stato sempre fatto rientrare nella figura della giustizia, che fa le parti. Ma le parti si fanno se si ha uno strumento comune che è il Logos che ci lega. Certamente questa semantica della componente razionale si può intendere in senso meno discorsivo e più penetrativo, se noi evochiamo quello che i Greci chiamavano il Nous. Cioè l’idea che nella vita umana c’è una capacità di attingere (tangere attraverso un moto a luogo) in maniera illuminata e non solo impulsiva, ad un piano della vita superiore. Allora qui lo sguardo della razionalità è ciò che ci porta a cogliere il bene.
Queste due accezioni dovrebbero dialogare tra di loro, ci dovrebbe essere un controllo reciproco. Questo lo collego, alla terza domanda – per poi tornare alla seconda – perché io ho insistito sul principio di differenza fra bene e male che poi va riempito di contenuti. Lungo le epoche il paniere del bene e il paniere del male è stato riempito di cose diverse, e la presenza di principi relativamente diversi in un paniere o in un altro, a seconda delle latitudini anche storiche, non ci deve far concludere affrettatamente che i due panieri sono uguali. Dobbiamo continuamente, attraverso il dibattito pubblico – perché non c’è un tribunale di cassazione che svuota i panieri e dice questo è ok, o non è ok -fare una supervisione intorno a questo principio. Certo la cifra del bene è quella cifra di promozione del magnanimo che si riconosce nella figura della crescita, della libertà, della pace, della convivenza e di quell’equilibrio a cui faceva riferimento Mignini. E sono anche delle figure che sono in continuità con la dinamica fisiologica; nell’ordine fisiologico non abbiamo nessuna esitazione nel dire che un cancro è patologico e uno stomaco che funziona bene sta nel fisiologico, perché il patologico è un parassita del fisiologico. A tal punto che quando si è mangiato tutto muore anche lui.
Da questa metafora, da non sottovalutare, possiamo trarre l’idea che il male non sta in piedi da solo.
Rispetto alla seconda domanda: sono stato molto tentato di entrare a fondo, perché sono stato toccato in profondità da ciò che ha detto Mignini. Perché io, nella mia fede, non posso accettare che Dio non parli. Non solo perché egli parla, ma perché ha parlato. Non posso accettare di circoscrivere nella semantica del concetto, perché c’è stato un avvenimento che mi ha toccato e che mi fa fare cose stranissime: in quanto credente mi fa inginocchiare davanti ad un microgrammo di pane azzimo.
Inoltre non mi sentirei di evitare la metafora personale, riferendomi a Dio, perché non potrei dialogare con un’idea. La metafora personale è il vertice del personale. All’opposto, però, sento che – nell’ordine della razionalità – il discorso fatto da Mignini sta in piedi, regge. Il problema sta nel mettere insieme ciò che lui dice e ciò che mi è capitato, e che capita da secoli a milioni di persone, alla quale non voglio rinunciare. Il credente deve mettersi in gioco, e questi sono i luoghi adatti per farlo.
La domanda posta è cruciale: riuscire ad usare la semantica della paternità e maternità in modo non antropomorfico. Questa è una grande sfida. Certamente l’antropomorfismo è un uso deteriore della metafora, però una rinuncia alla metafora porta direttamente al silenzio. E qui Mignini è stato di una coerenza assoluta.
Io debbo riuscire a trovare le parole, perché secondo me Dio parla, e parla continuamente. Mi sta dicendo, a me stasera, moltissime cose. Mi parla attraverso voi, le vostre parole, i vostri sguardi, un bambino che mi attraversa la strada… Dio parla attraverso le persone più impensabili, che sbagliano i congiuntivi, che non si lavano… Dio parla così.
Devo continuamente dimostrare che non sto diventando paranoico agli occhi di chi non ha avuto la mia stessa esperienza di vita.
Prof. Mignini: sul rapporto fra etica e ragione direi che non c’è nessun altro rapporto possibile, cioè l’etica è soltanto fondata sulla ragione. Su che cosa vorremmo fondarla, sennò? Quando Ricci dialoga con il letterato cinese tutti e due convengono nel dire che la ragione sta all’uomo come il sole sta al mondo. Cioè: la luce che illumina questo mondo è il sole, e l’unica luce che possa illuminare l’uomo è la ragione. Per me non ci sono dubbi a riguardo.
La questione del Dio-giudice o guida o conduttore: io ve l’ho detto, per me sono antropomorfismi, cioè Dio non guida e non giudica. Ma non guida e non giudica nel modo che noi, abitualmente, consideriamo come tale nella nostra esistenza umana. Perché, al contrario, noi non facciamo nulla senza la guida di Dio, senza il giudizio di Dio. Ma dove per Dio io non intendo uno che sta lì e che guarda e che osserva, con il suo occhio su di noi, per poi giudicare i miei atti.
Il giudizio di Dio si manifesta nella natura, nell’uomo e nelle relazioni sociali, nella realtà concreta delle nostre situazioni. Tu sbagli e nel tuo errore c’è il giudizio, ma è chiaro che questa sia una metafora. Se tu ti comporti conformemente a ragione e conduci la tua vita in modo tale che sia utile alla costituzione di una società, in questo sei guidato da Dio: ma non nel senso che Dio sta lì come un soggetto esterno che ti muove, ma nel senso che hai interpretato perfettamente ciò che è necessario all’ordine naturale, umano.
Perché Dio non può comunicare, mi si chiede?
Perché Dio non ha alcun bisogno di comunicare, così come noi intendiamo la comunicazione. Dio comunica continuamente, attraverso il nostro essere, la nostra ragione, l’essere degli altri, le situazioni, i contesti. Attraverso la realtà. È la realtà che comunica con noi, questa è la comunicazione. Non certo Dio si muove va da qualcuno e gli dice cosa ha fatto bene e cosa dovrebbe fare. Come comunicherebbe, Dio? Attraverso quale lingua? La lingua araba? Il Corano è scritto in lingua araba e gli islamici sono convintissimi che Dio abbia comunicato con loro in lingua araba, e al di fuori dell’arabo non c’è una lingua che si possa utilizzare correttamente la rivelazione divina. Ma vogliamo scherzare? Oppure l’ebraico? O il latino? O il greco?
Per fortuna i cinesi questa idea non ce l’hanno mai avuta, non hanno mai pensato che la divinità potesse rivelarsi a qualche loro imperatore o saggio.
Questa idea, invece, è costitutiva delle tre religioni del libro, i tre grandi monoteismi. Certo, anche gli antichi poeti immaginavano che gli dèi scendessero dall’Olimpo, andassero a fare le loro marachelle, e comunicassero in qualche maniera con gli uomini, ma stiamo parlando di miti. Qualcuno che incominciò a dire di lasciar stare la divinità, perché è una cosa seria, e che andava considerata in modo diverso, ci ha lasciato le penne, ha dovuto bere la cicuta.
Il discorso che parte con il dire se a Dio è piaciuto farlo io non lo capisco. Se tu mi dici che a Dio piace fare qualcosa io non capisco ciò che dici, come non capirei se mi dicessi che due più tre fanno sei. Non so quello che dici. Perché Dio non è un soggetto di piacere, a lui non può piacere nulla. Come fa Dio ad avere degli affetti? O dei sentimenti? Questi ce l’hanno gli uomini, gli animali. L’Assoluto non può provare sentimenti, come fa a provare piacere o dispiacere, amore o odio, disappunto o misericordia? Tutto ciò non è possibile, assolutamente impossibile. Tutto questo teniamocelo per noi, per costruire le nostre relazioni sociali ed umane.
In merito alla distinzione tra bene e male si deve dire che è una distinzione che noi poniamo dove, concretamente, è bene ciò che le leggi stabiliscono come tale, male ciò che le leggi proibiscono. Per ciò che le leggi non stabiliscono (perché le leggi non stabiliscono tutto) la differenza tra bene e male ce la dice la ragione. Affidiamoci alla ragione.
La legge non mi dice in dettaglio e in concreto come mi devo comportare con mia moglie, però la ragione sì. Certo: la legge regola, nelle linee fondamentali, i rapporti tra marito e moglie, ma non regola tutti i minuti e tutte le ore della tua giornata. Negli ambiti dove la legge non dice nulla, deve intervenire la ragione e l’esperienza.
Come si fa a fondare una società togliendo il tema dell’alterità?
Si pretende che, in questo caso, l’alterità sia quella di Dio, cioè di un soggetto altro. Io direi che ce n’è in abbondanza, tra gli uomini, di alterità. Cioè l’alterità con la quale abbiamo a che fare nel costruire le leggi, è l’alterità umana, l’altro individuo col quale mi devo mettere d’accordo per concordare una Costituzione, cioè una serie di elementi fondativi per questa società. Ma non c’è bisogno di scomodare Dio, per questo. Ci sono stati centinaia di migliaia di anni, alle nostre spalle, che ci hanno spinto dove siamo arrivati. Siamo ancora molto imperfetti, abbiamo ancora molto da imparare, ma tutto quello che è alle nostre spalle è l’esperienza che abbiamo compiuto; l’abbiamo compiuta avendo una infinita di idee di Dio e di divinità, ciononostante siamo arrivati recentissimamente ad avere, per esempio, un’idea di diritti fondamentali dell’uomo, o di una società delle nazioni. Siamo arrivati a dei risultati solamente attraverso la nostra esperienza, in questo oserei dire che l’idea di una divinità ci ha aiutato, ma le idee sono state molto diverse. Altre volte ci ha anche ostacolato, perché i conflitti tra questi dèi (basta guardare i primi libri della Bibbia dove il popolo ebraico, il popolo di Dio, deve affrontare gli altri dèi e gli altri popoli) è stato molto sanguinoso e violento.
Per concludere: io non dialogo con un’idea, perché il Dio che ho descritto non è un’idea di Dio. Il Dio di cui parlo è l’esistenza stessa, è la necessità dell’esistenza. L’essere necessario che ha in sé tutto quello che noi possiamo apprezzare nelle manifestazioni di quest’essere. Tutto questo, però, ha a che fare con la nostra esperienza determinata, con la nostra esperienza di uomini finiti. Ed è in questo ambito di finitezza e determinatezza che io costituisco il mio destino. Io dialogo con gli altri uomini, non con Dio – che non mi sente – ma sapendo che gli altri uomini ed io stesso, siamo espressioni e manifestazioni finite, determinate e limitate della stessa necessaria esistenza.
Domande dall’uditorio:
5. Stasera si sono fronteggiate due idee di etica e di moralità, fondate – però – sulla virtù. Cioè fondate su ciò che la razionalità suggerisce, o detta. Ma vorrei chiedere: se concediamo un po’ più di spazio ad un’etica della libertà, cioè ad un’etica in cui la razionalità può suggerire qualcosa che poi la volontà può non seguire, come è possibile che non si arrivi a sconvolgere il mondo che abbiamo tra le mani? Come si può opporre, in quella necessità di cui parlava Mignini, una libertà che vada contro la necessità che la razionalità ci “consiglia” di seguire?
6. Io mi interrogavo su un’affermazione del professor Mignini, quando parlava di un Dio che non ascolta e che non ha parola. Lei, di fronte anche all’infiltrazione dell’eterno nel tempo, data dalla rivelazione cristiana, di Cristo, sarebbe ancora così convinto ad affermare che Dio non parla, non sente, non ci ascolta?
7. Una domanda per il professor Alici, in quanto Mignini ha già risposto ponendo il fatto che Dio non parla: se Dio parla, da cristiano, come faccio a distinguere quello che Dio mi dice da quello che io penso che Dio mi dica?
Prof. Alici: Una battuta sulla prima domanda, sulla parte che può riguardarmi: quando si dice etica della virtù non si intende dire un’etica ottimistica che mette tra parentesi il male, perché la virtù è una medaglia in cui nel retto c’è la virtù e nel verso c’è il vizio. Quindi un’etica della virtù non va intesa come una visione che minimizza il male nel mondo; rispetto all’enfasi sulla libertà, l’etica della virtù si preoccupa di quelle forme in cui il cammino verso la libertà si stabilizzano, diventano abiti e cerca di incorporare la durata. Ma anche la logica del male funziona così, quindi la logica della virtù è sempre tallonata dal vizio.
Quanto al male: secondo me il male non si integra, l’inferno non si integra. L’inferno sulla storia c’è, Auschwitz c’è, ma non si integra nella storia. Se noi abbiamo una visione secondo la quale Auschwitz è parte della storia io salto sulla sedia. Auschwitz non si integra.
C’è un racconto di Elie Wiesel, ne La notte, terribile, relativo all’impiccagione di un ragazzino, chiamato L’angelo dagli occhi tristi. Basta quella roba lì, una sola, per far emergere il male, non è che serve una somma cumulativa, per formare il male. Basta l’impiccagione di un bambino a rappresentare un buco nero che non si integra alla storia. Ma che vogliamo dire, che è funzionale all’armonia dell’insieme? No, no, questo non sarei mai disposto ad accettarlo.
La terza questione è impegnativa, perché la fede corre sul filo della superstizione, del fideismo, dell’antropomorfismo. Il prezzo però che pensiamo di pagare per evitare questi pericoli, se noi spegniamo l’interruttore dello spirito per paura di sentire delle voci che ci fanno andare fuori binario, è un prezzo troppo alto. È un rischio da correre, invece. La tradizione cristiana lo corre attraverso il tema della comunità, perché l’avventura della fede non si compie mai da soli. Come in una famiglia ci si conosce, ci si capisce e ci si migliora, la fede è dinamite nella vita delle persone. Ed anche l’amore è così. L’amore è dinamite allo stato puro: per un rapporto finito male due ragazzi si ammazzano. Tutte quelle dinamiche che appartengono alla scala dell’amore sono esplosive, da maneggiare con cure.
Prof. Mignini: La prima questione mi fa venire in mente un’altra frase di Dostoevskij che suona più o meno così: non v’è dubbio che all’uomo piaccia costruire strade, ma da che cosa dipende che sia così attratto dal negativo, dall’errore e dall’orrore?
Se non ho capito male tu consideri la libertà quello spazio, quella potenzialità che fa sì che uno non segua la ragione. Se ho capito bene, sono sicuro che ti sbagli. Se invece ho capito male correggimi. Questo poter non seguire la ragione io non la chiamerei libertà, ma la chiamerei schiavitù, ignoranza, mancanza di quella conoscenza chiara e distinta delle cose che ti induce a seguire il bene e a evitare il male.
I misfatti della storia fanno parte della storia, non ho ben capito cosa intende Alici quando dice che il male non si integra nella storia. Per la miseria, purtroppo, i misfatti fanno parte della storia, eccome. Se fanno parte della storia significa che esprimono, con lo stesso diritto, purtroppo, la natura umana. Così come esprimono la natura umana le grandi opere o i gesti più magnifici. Il problema è da capire come mai, nella natura umana, ci si esprima continuamente con queste due possibilità. Delle risposte sono state date negli ultimi decenni, nell’ultimo secolo, attraverso una teoria delle pulsione. Non dimentichiamo che noi veniamo da una lunga storia dentro la quale la nostra esperienza pulsionale si è affinata, ci ha portato dove siamo. I due gemelli eterni, eros e thanatos, che albergano dentro di noi e che lottano in continuazione ci sono e non ce ne possiamo liberare. Dobbiamo, piuttosto, imparare a maneggiarli.
La libertà, allora, sta nel conoscere. Il problema, ora, che sorge sarebbe: come si fa a far sì che la maggior parte degli uomini si trovi nella condizione di poter costruire strade, invece di distruggere ponti. Come si fa?
Gli uomini hanno elaborato un mezzo, tale mezzo è la politica. La politica prevede che ci sia un sistema educativo, un sistema di formazione, un sistema attraverso il quale ciò che è stato capito prima venga trasmesso a quelli che vivono oggi e di seguito…Insomma: la partita ce la giochiamo qui, ce la giochiamo nel far funzionare la politica, perché è l’unico antidoto che abbiamo alla distruzione.
Mi è stato chiesto se dinanzi a Cristo sia ancora sicuro di quanto ho affermato: io rispondo che sono sicurissimo che l’eterno costitutivamente intessa la storia, insomma non ho bisogno di Cristo per dire e scoprire questo. Che poi Cristo sia stato una figura che, nella storia, merita un luogo di assoluto rispetto, ecc. è fuori discussione. Ma che il temporale non possa darsi se non in quanto innestato nell’eterno, io di questo sono convinto, illuminato dal misero lume dell’intelletto naturale, e per dire ciò non ho bisogno di Cristo. Non vorrei offendere nessuno, ma non ho bisogno di Cristo.
All’ultima domanda, che non mi è stata posta direttamente, vorrei rispondere comunque: quando dico che l’Essere non comunica io non dico che non comunica assolutamente, non comunica more umano. Cioè non si manifesta un profeta che è spesso un pover’uomo al quale la scrittura, continuamente, sottolinea pace su di lui, pace su di loro… Però: quegli insegnamenti, una volta depurati di molte scorie, di immagini e metafore, sono insegnamenti che corrispondono agli insegnamenti della ragione. Ora la domanda che lei ha fatto è davvero insidiosa, perché solleva il grande problema dell’esegesi dei testi. Qui ci sono state due modalità fondamentali, nella storia: una è quella per cui il diritto del deposito ce l’ha il magistero nella Chiesa Cattolica, l’altra è quella individualistica della svolta protestante. Lei scelga quella che vuole, però ci sarebbe una terza strada che non passa né per la prima, né per la seconda e che, molto modestamente, ho provato a dimostrare.
Lettera a Umberto Eco
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Sossio Giametta ad Umberto Eco
Milano, 10 maggio 2013
Ill.mo e caro Eco,
ebbi il piacere di salutarla alla serata in onore di Raffaele La Capria. Lei mi disse di aver ricevuto il mio libro, L’oro prezioso dell’essere, ma di non averlo letto. Tutto normale. Immagino le montagne di libri che le arrivano. E poiché le arriveranno anche montagne di lettere, invoco il suo generoso perdono per il mio farmi vivo pur sapendo tutte queste cose. Perché lo faccio? In generale perché noi poveri autori non famosi non possiamo onestamente sperare che nel riconoscimento di coloro che possono capirci, e perché in particolare io ho motivi personali per rivolgermi a Lei. Credo infatti di aver fatto una scoperta che, se è fondata, non può non interessarla quale filosofo e commentatore degli evi antico, medio e moderno. Questa presunta scoperta riguarda appunto l’evo moderno, sul quale è uscito ultimamente un libro da Lei curato.
Approfondendo lo studio semisecolare di Nietzsche, sono arrivato a capire il suo genio profondo, da tutti ancora ignorato e insospettato, e poiché esso è, secondo me, il punto d’approdo della modernità, sono arrivato a capire anche il senso, tuttora ignorato e insospettato, della modernità. Questo è un processo unitario, drammatico, angoscioso, che impone la reinterpretazione dei suoi protagonisti in base alla posizione da ciascuno occupata in esso. Tutto ciò è contenuto nel capitolo mediano del libro, intitolato Come fu che intuii quello che avevo capito. Ma per non obbligarla a leggere il libro, lo ripeto qui in altra forma.
Un nuovo studio su Reimarus
Nella sezione RF Edizioni è possibile scaricare un nuovo contributo su Hermann Samuel Reimarus. Presa in esame è la questione del miracolo. Se il mondo religioso ha per lungo tempo considerato il miracolo come elemento probante della rivelazione, pensatori come Spinoza, Lessing e Reimarus hanno invece sottolineato l’inconciliabilità tra le ragioni del fedele e quelle del filosofo.
La religione, nel bene e nel male
Negli ultimi giorni, come spesso accaduto recentemente, il dibattito pubblico ha riproposto il tema del ruolo della religione, ed in particolare del cristianesimo, nell’ambito della società. Gli interventi sono stati diametralmente diversi, a riprova del fatto che la religione costituisce un tema sempre aperto e dagli esiti incerti. Abbiamo pensato di dare conto di alcuni di questi contributi insieme ad una nostra guida ragionata.
Cristianesimo minacciato?
Ernesto Galli della Loggia, noto editorialista del Corriere della Sera, ci informa in un articolo apparso domenica 2 giugno 2013, che è in atto in Europa una gigantesca rivoluzione antireligiosa che si presenta, per ovvie ragioni storiche e culturali, come una grande rivoluzione anticristiana. I fatti che lo storico porta a dimostrazione di questa tesi sono principalmente una serie di offese ed altre “sanguinose contumelie” tratte da una denuncia del quotidiano Avvenire e dal sito web intoleranceagainstchristians.eu. Galli della Loggia continua sostenendo che i segnali di questa persecuzione anticristiana sarebbero poi la cancellazione dell’erogazione di fondi alle istituzioni cristiane; il fatto che in alcune sedi scolastiche le vacanze invernali avrebbero sostituito, nella dicitura ufficiale, le tradizionali vacanze di Natale; la cancellazione della libertà di coscienza nelle professioni mediche e paramediche. Tutti casi che dovrebbero suscitare la preoccupazione di qualunque coscienza liberale.
Noi di RF, che religiosi non siamo ma liberali sì, non neghiamo che si siano verificati e si verifichino atti di violenza verso i cristiani ma avvertiamo una sorta di insopportabile rovesciamento del problema. “L’intolleranza verso la religione” recitava l’occhiello dell’articolo: la portatrice storica dell’intolleranza, ora sarebbe divenuta a sua volta oggetto di intolleranza. Sembra un ossimoro. O forse una nemesi. Qualsiasi cosa sia, l’idea della rivoluzione anticristiana in atto, che determinerebbe un’inversione di tendenza in un dominio bimillenario e spesso violento esercitato dall’autorità religiosa nei confronti di chi non si sottomesse al suo dominio, è sproporzionata, così come la tesi secondo la quale la libertà dei cristiani appare “oggettivamente” in pericolo.
In primo luogo, tale tesi poggia su un elenco di singoli casi forniti dal quotidiano dei Vescovi italiani e da un osservatorio europeo di ricerca. Per quanto degne di essere prese in considerazione, riteniamo che esse non siano paragonabili, per una seria analisi storica, alle violentissime persecuzioni imbastite per secoli contro il pensiero liberale italiano ed europeo. Per restare alla storia moderna, ricordiamo soltanto le persecuzioni protonaziste contro gli ebrei da parte cattolica avvenute in Spagna e Portogallo alla fine del XV secolo; le terribili guerre di religione dei secoli successivi; le umiliazioni che fino ad epoca recente, intellettuali, uomini di cultura, pubblici impiegati hanno dovuto affrontare per dichiarare la propria fedeltà ad un’opinione che non era la loro.
In secondo luogo è quantomeno singolare che il quadro riportato da Galli della Loggia non tenga conto della fortissima posizione di potere che la religione cristiana conserva abbondamente in Italia e in Europa. Posizione di potere che permette, ad esempio, di coprire una lunga storia di abusi e violenze nei confronti dei minori; di beneficiare di un rango tuttora privilegiato nei confronti delle altre religioni e che in Italia pone la Chiesa cattolica (nonostante la modifica dei Patti concordatari) come autentica religione di Stato. Si potrebbe continuare citando il finanziamento operato con l’otto per mille, le esenzioni fiscali, le norme ancora in vigore nei codici a tutela della religione, le nuove leggi restrittive in tema di etica, la gestione educativa delle giovani generazioni che la Chiesa si arroga come un diritto (e che, va detto, molte famiglie le riconoscono). Noi non arriviamo a dire che questi fatti siano da considerare come prova di una persistente negazione dei diritti da parte cristiana. Ma che si debba rovesciare la frittata spacciando la pur innegabile diminuzione di influenza del cristianesimo come una persecuzione contro i cristiani è francamente eccessivo e suona come una presa in giro. Che cosa deve temere la religione in un Paese, tanto per rimanere in Italia, dove i più grandi pensatori laici e liberali sono stati spesso ridotti in cenere, fisicamente e metaforicamente? Dove la tradizione filosofica che più ha messo radici, quella idealistica, è figlia di un sistema (quello hegeliano) che ha saldato in modo granitico la ragione all’assoluto cristiano? Dove il fondatore dell’illuminismo europeo, Spinoza, è sinonimo di un sito di barzellette? Abbiamo da poco assistito all’elezione del nuovo papa alla cui cerimonia erano presenti i potenti provenienti da tutti gli angoli della terra: non ci risulta che lo stesso accada, non dico per la Merkel o per Napolitano, ma almeno per Obama o per Xi Jinping. Come evidenziato poi dallo splendido numero di aprile di Limes, L’Atlante di papa Francesco. Hic Petrus hic salta. La strategia della Chiesa per riconquistare il mondo, i dati mostrano che la religione cattolica non è affatto in ritirata e che anzi sta godendo (complice la crisi e lo scontro con il fanatismo islamico) di una nuova e rinnovata linfa vitale a livello mondiale. Non si vede perché questo non debba avvenire anche in Europa dove del resto non basta (ad ulteriore prova di quella tesi di Galli della Loggia) che il mainstream dell’opinione pubblica non si alzi mai a sostegno del punto di vista dei cattolici: questa è veramente una preoccupazione da accademici che non conosce la pancia del popolo dove la popolarità e il consenso nei confronti della Chiesa ha radici forti e antiche.
Per finire segnaliamo un’ultima contraddizione. Se è vero, come dice Galli della Loggia, che la libertà religiosa ha rappresentato storicamente l’origine e la condizione di tutte le libertà civili e politiche, è anche vero che si è trattato della lotta di un potere religioso (la riforma protestante) contro un altro potere religioso (la controriforma cattolica) in nome di quella tendenza a ridurre il cristianesimo a fatto privato capace di produrre le attuali libertà politiche e personali. Il fatto di quella riduzione, che non sembra piacere a Galli della Loggia, è esattamente la premessa della conclusione che si vuole mantenere.
Nuovi atei, nuova Chiesa.
Di tutt’altro tenore l’articolo di Giancarlo Bosetti di Repubblica del 3 giugno per il quale invece la fase di aggressione antireligiosa ha oggi lasciato il passo a riflessioni più moderate fino a farsi strada un pensiero laico aperto al dialogo. L’articolo discute della religione in generale e valuta il processo di apertura del laicismo. Il cambiamento di stagione è avvenuto soprattutto in ambito anglosassone, dove del resto più forti erano stati gli accenti antireligiosi avvenuti a seguito degli eventi dell’11 settembre. Anche per quanto riguarda l’atteggiamento verso il cristianesimo, non si registrano più gli attacchi che in passato venivano sferrati contro i credenti e che coincidevano sostanzialmente nell’accusa della loro minorità intellettuale.
Centrato invece esplicitamente sulla Chiesa cattolica l’articolo di Giuliano Ferrara del 25 maggio nel quale l’istrionico direttore del Foglio celebra l’avvento di papa Francesco come la fine del Concilio Vaticano II. Per usare un gergo che sarebbe a lui caro, la Chiesa del concilio è stata preda di troppe seghe intellettuali, di troppe pippe dialettiche, di eccessivo sinistrismo politico. Con l’avvento di Francesco si ha finalmente un papa che non ha problemi, continua il suo stretto collaboratore Maurizio Crippa, né quello del Concilio, né quello del moderno e del post-moderno. Dopo papa Luciani, secondo cui il vero dramma della Chiesa che ama definirsi moderna è il tentativo di correggere lo stupore dell’evento di Cristo con delle regole, si è finalmente spazzato via il blabla clericale. Bergoglio ha dunque finalmente voltato pagina e ha superato la storica impasse costituita dal Vaticano II. «Un gesuita – scrive Ferrara – che parla del diavolo e lo frequenta a Santa Marta per infilzarlo ogni mattina in un’omelia serenamente non protocollare, che lascia vuoti, museali, i palazzi apostolici, che fa della diocesi romana la sua grande Madonna protettrice, che persegue scopi con i mezzi relativi della spiritualità discernente, ignaziana. Cazzo che papa». Un papa che definisce pietose le associazioni filantropiche di carità e poi va a ricevere l’abbraccio della folla sotto la pioggia battente. L’astuzia della ragione è davvero ben poca cosa a confronto con l’astuzia della religione.
Fede e ragione unite nel misticismo?
Prendendo spunto dal rinnovato interesse nei confronti della Chiesa che si è avuto a seguito dell’elezione di papa Francesco, è apparso lunedì 15 aprile nelle pagine culturali di Repubblica un contributo di Marco Vannini, noto teologo e grande studioso del misticismo, sul rapporto tra fede e ragione. La tesi dell’articolo è che il conflitto tra fede e ragione, così come si è dato storicamente, è in realtà frutto del modo errato con il quale vengono intesi quei due concetti. Il conflitto si ha soltanto quando fede e ragione non sono se stesse: la fede, lungi dall’essere credenza o superstizione, è definita come vero sapere che non dipende da un determinato fatto storico; la ragione, intesa in senso pieno e non ideologico, trova invece la sua reale dimensione nel riferimento all’assoluto. Se intese in questo modo fede e ragione finiscono per parlare lo stesso linguaggio e possono senz’altro andare d’accordo.
Vannini, a sostegno della sua tesi, cita diverse tradizioni: le Upanishad, uno dei documenti principali delle religioni asiatiche, le quali affermano che «Solamente quando si ha fede si pensa: chi non ha fede non pensa. Pensa solamente colui che ha fede»; il Vangelo, che condanna la credenza superstiziosa nel momento in cui i miracoli prendono il posto della vera fede; la tradizione mistica per la quale l’interiorità e la riservatezza sono il luogo autentico dove risiede la divinità.
Il problema, come riconosce Vannini alla fine dell’articolo e su cui però non ci dice nulla, è quello di capire quanto tutto questo sia compatibile con le forme di cristianesimo e di chiesa oggi storicamente presenti.
Su questo noi di RF avremmo qualcosa da aggiungere. In primo luogo osserviamo che la tesi dello studioso si inserisce in una lunga tradizione mirante a conciliare fede e ragione dal lato della ragione. Sul piano storico, la ricerca di una compatibilità simile a quella indicata da Vannini è spesso avvenuta per opera dei sostenitori di una ragione aperta a Dio, mentre i rappresentanti della fede si sono spesso rinchiusi all’interno dei più comodi recinti religiosi e del facile consenso politico. La tesi di Vannini non è nuova ed è quella per la quale hanno lottato i grandi pensatori di tutti i tempi che, dentro o fuori le istituzioni religiose, hanno affermato l’unità del genere umano in nome dell’humanitas. Il vero problema religioso del nostro tempo dunque è in realtà il problema di tutti i tempi e numerosi sono gli ostacoli alla sua soluzione. Da un punto di vista più specifico, solo per rimanere agli argomenti portati dall’autore riguardo al Vangelo, si potrebbe dire che se è vero che Gesù condanna i miracoli quando prendono il posto della fede, è anche vero che la fede implica la fede nei miracoli, ovvero ciò che ripugna alla ragione. Ma in generale l’ostacolo più serio è costituito dal conflitto, interno alla fede, tra la teologia sapienziale (che sottende la posizione di Vannini) e la teologia dell’incarnazione (che si è realizzata storicamente): di fronte a tale scelta, il cristianesimo non ha mai rinunciato alla seconda, cioè allo scandalo della croce, al Cristo incarnato e risorto, stoltezza per le altre religioni e follia per gli uomini governati dalla ragione.
Non ci sono le condizioni dunque per ricercare un accordo sul piano del misticismo. L’unione di fede e ragione può, secondo noi di RF, avvenire soltanto dopo che si sia riconosciuta la totale separazione tra i due ambiti, diversi per metodo e oggetto. Solo dopo che si sia ammesso ciò è possibile riconoscere il solo punto in comune che permette un loro accordo: la prassi etica di giustizia e carità. Non si tratta di una tesi accomodante perché implica che entrambe le parti si mettano in discussione: i sostenitori della fede rinunciando all’apparato di dogmi e teologie messianiche; i fautori della ragione ammettendo che la vera filosofia non è soltanto ricerca della conoscenza ma anche agire personale secondo l’idea della filosofia come insegnamento di vita.
Togliere la sordina a Machiavelli
Il 2013, come ormai noto, sarà dedicato alla celebrazione dei cinquecento anni dalla pubblicazione del Principe di Machiavelli. Ormai dall’inizio dell’anno, ogni settimana, è un susseguirsi di convegni, seminari, trasmissioni radiofoniche, saggi e articoli sul tema in questione. L’ultimo è quello apparso oggi sul Foglio di Giuliano Ferrara. Due pagine scritte da Stefano Di Michele il quale vuole tratteggiare una lettura sui caratteri biografici e intellettuali del segretario fiorentino. Nel sottotitolo si dice che Il Principe è «il libro più importante dei tempi moderni, un impasto di arte della politica, filosofia della storia, scienza e tattica del potere, psicologia dell’esistenza affacciata sul vuoto». L’articolo, costruito in gran parte sugli aspetti biografici, si sofferma essenzialmente sulla disgrazia di Machiavelli impegnato, suo malgrado, nelle bettole e nelle osterie nelle quali trascorse la seconda parte della sua vita a causa dell’esilio nel quale fu condannato a partire dal 1512. Di Michele ricorda così come il Principe sia nato da una grande ed umanissima disperazione, «quella di un genio stanco e umiliato che tentava di tornare al centro delle cose».
E tuttavia anche questo articolo, come molti contributi che fin qui abbiamo letto in questo inizio di centenario, dimentica (chissà se più o meno consapevolmente, vista l’impostazione dichiaratamente “devota” di quel giornale) il fatto che Machiavelli è stato essenzialmente e prima di tutto un autore anticristiano. E questa verità, da cui non si può prescindere se si vuole davvero affrontare il pensiero di questo autore, ce l’ha ricordata in una recente trasmissione su Radio 3 proprio Gennaro Sasso, il più grande ed acuto studioso di Machiavelli che abbiamo oggi in Italia. Machiavelli non è tanto e solo un pensatore anticlericale (anzi si può in realtà dubitare che esso lo sia effettivamente), quanto un pensatore che ha messo in crisi i fondamenti del pensiero cristiano. Trascriviamo, perché lo merita, la parte finale del dialogo dello studioso con l’intervistatore:
Sasso: Mi sono convinto di una cosa: che questo autore non è mai stato letto nelle cose essenziali (…). È possibile che non abbiamo capito che per Machiavelli l’Italia non esisteva, non riusciva ad esistere e che bisogna fondarla in modo profondo? E che per fondarla in modo profondo bisognava realizzare una serie di riforme etico-politiche in cui il problema fondamentale fosse il rapporto con la Chiesa? Perché questo è il nocciolo del pensiero di Machiavelli. Lei prima citava la Svizzera: ma Machiavelli dice che se noi trasportassimo la sede della Chiesa romana nella incorrotta Svizzera in capo a due generazioni la Svizzera sarebbe corrotta come noi. E questo anticipa il punto per cui la storia italiana è nata…(interrotto, ndr)
Intervistatore: Ma allora questa ferita è originaria, intatta!
Sasso: Sì…sì…In questo senso Machiavelli è veramente un autore rivoluzionario che è stato messo tra parentesi, che è stato allontanato…Perché io sono convinto che anche i più grandi estimatori di Machiavelli, nel dettaglio, non hanno mai veramente detto che Machiavelli non è uno scrittore cristiano. Potrà piacere, potrà dispiacere, uno può anche rimanere indifferente per rispetto a questa questione. Scientificamente però uno ne prende atto. Machiavelli non è uno scrittore cristiano e lo dice, lo dice…e lo scrive e sposa dottrine che sono definite anti cristiane nell’ambito della cultura teologica. In un capitolo dei Discorsi Machiavelli scrive sulla eternità del mondo. Ora, quando uno dice che il mondo è eterno, vuol dire che non è creato e se il mondo è eterno non c’è Dio che lo crea. Adesso, per dire le cose in maniera molto, molto…(interrotto, sigh, ndr)
Intervistatore: Ma allora Gennaro Sasso sta elevando la categoria del non cristianesimo o anticristianesimo di Machiavelli ai fondamenti…
Sasso: Guardi, avendo avuto la ventura di studiarlo per molti e molti anni e di esserci tornato spesso, mi sono reso conto tardi di questa cosa, me ne sono reso conto tardi. Perché? Ma perché c’era un condizionamento a tenere in sordina questo tema, a considerarlo una nota di anticlericalismo…(nuovamente interrotto, sigh, ndr)
Intervistatore: Soprattutto qualcosa legato ai tempi, alla particolare corruzione, i Borgia…
Sasso: Se uno considera l’atteggiamento di un altro grandissimo personaggio contemporaneo di Machiavelli, Francesco Guicciardini, nei confronti della Chiesa, beh le pagine di Guicciardini sono ancora più potenti di quelle di Machiavelli nella esecrazione della Chiesa. Chiesa che poi, d’altra parte, il Guicciardini era costretto a servire a differenza di Machiavelli…Ma non si può dire che Guicciardini sia anticristiano…per Machiavelli sì e su questo bisogna battere l’accento: può piacere, può dispiacere ma Machiavelli è questo. Ed è per questo che non è un autore della letteratura italiana e chi si è avvicinato a Machiavelli, anche laicamente, ha messo la sordina su questo punto.
Intervistatore: Allora questa sordina l’abbiamo strappata!
Sì l’abbiamo proprio strappata, aggiungiamo noi. Ora deve decidersi a farlo anche la cultura e il pensiero storico-filosofico italiano (e possibilmente anche quello della divulgazione quotidiana) se non si vuole condannare al permanente esilio post-mortem questo straordinario pensatore.
L’agnosticismo intollerante
Nel discorso del 6 gennaio rivolto ad alcuni vescovi di fresca nomina, papa Benedetto XVI si è scagliato con inaudito vigore contro l’agnosticismo. «L’agnosticismo oggi largamente imperante ha i suoi dogmi ed è estremamente intollerante nei confronti di tutto ciò che lo mette in questione e mette in questione i suoi criteri». Ben diverso il tenore del discorso tenuto ad Assisi nel settembre del 2011 quando invece gli agnostici erano considerati «persone che soffrono a causa dei peccati dei credenti e più vicine al Regno di Dio di quanto lo siano i fedeli di routine». Se non si vuole attribuire incoerenza alle parole del papa, l’agnosticismo si compone ora di due categorie, quello buono e quello cattivo. Una strana partizione per coloro che si dichiarano scettici nei confronti della conoscenza prescindendo dalle categorie di bene e di male.
Quello del papa è in realtà un discorso che ripropone i tratti tipici della violenza religiosa. Questa volta però, grazie alla fortunata circostanza in base alla quale la Chiesa cattolica non esercita più direttamente il potere politico, il suo capo invoca eroismo per i vescovi tramite la capacità di attirare la violenza su di sé: «E tale valore o fortezza non consiste nel colpire con violenza, nell’aggressività, ma nel lasciarsi colpire e nel tenere testa ai criteri delle opinioni dominanti». Ammesso e non concesso che sia necessario ribadire concetti simili – chi ha mai pensato che il valore e la fortezza consista nell’aggressività? Forse il pontefice si riferisce a passate abitudini della Chiesa? – questo appello all’essere percossi colpisce, è il caso di dirlo, perché ripetuto più volte nel discorso, accentuando la sensazione di avere a che fare con qualcuno che parli con lo scopo di cercare deliberatamente la provocazione.
Vorremmo tranquillizzare il pontefice. La violenza di cui parla può essergli data, come purtroppo avviene in alcune parti del mondo, soltanto dalle religioni come la sua e non certo da agnostici o da coloro che sono gli autentici cercatori della verità, ovvero i filosofi. Per questi infatti non solo non esiste ricorso alla violenza (come ampiamente dimostrato dalla storia) ma, per molti di loro, non si dà nemmeno un cammino verso la verità. Questo per il semplice motivo, come diceva l’apostolo Giovanni, che noi tutti agiamo, ci muoviamo e siamo in Dio (1 Gv 4, 16) così che da sempre l’uomo dimora nella verità.
Eppure il papa insiste su questo tema. «La ricerca della verità era per loro – cioè i magi, ndr – più importante della derisione del mondo, apparentemente intelligente». Si ripropone uno schema classico, quello dell’audizione di San Paolo di fronte ai filosofi di Atene, narrato in Atti 17, 16-34: «Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dissero: Ti sentiremo su questo un’altra volta». Ma si dimentica tuttavia che il vero discorso aeropagitico è oggi soltanto quello della filosofia che da duemila anni vive nella città dominata dalle religioni.
Il discorso del papa dimostra ancora una volta il grande complesso di inferiorità della religione nei confronti della filosofia. La ricca religione, pur avendo tutto dalla sua parte (dogmi, numeri, forza organizzativa, appoggi politici ecc.) manca dell’unica cosa di pertinenza della povera filosofia: la verità. E da sempre la prima tenta di sottrarre alla seconda questa sua prerogativa. Per una sorta di curiosa eterogenesi, i credenti e il papa finiscono per fare la figura dei farisei nei confronti del cieco nato, così come mirabilmente riportato nel lungo e straordinario brano del vangelo di Giovanni (Gv 9, 1- 41). Dopo le loro continue ed incredule indagini, prima tra la gente e poi con i genitori, i farisei finirono per domandare irritati al cieco guarito da Gesù: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? E questi rispose loro: ve l’ho già detto e non mi avete ascoltato: perché volete udirlo di nuovo? Volete diventare anche voi suoi discepoli?». A questa acuta contro-domanda, che scopriva le loro segrete intenzioni, quelle cioè di voler essere come Gesù, i farisei persero la ragione e finirono per insultare prima e cacciare poi il cieco guarito. La Chiesa sembra oggi essere come quei devoti religiosi, desiderosa, ma incapace, di essere autentica discepola della verità. Ed è proprio questa sua impossibilità a generare la violenza.
All’infuori di qualche timido cinguettio, non sappiamo se alcuni tra agnostici o filosofi abbiano risposto al papa. Certo, la filosofia non ha un pontefice che può parlare ex cathedra avvalendosi di potenti strumenti di comunicazione. La religione tuttavia, nonostante tutte le apparenze contrarie, è più debole nei confronti della filosofia così come il mito è più debole della verità e la tecnica più debole della necessità (e la tirannia più debole della democrazia).